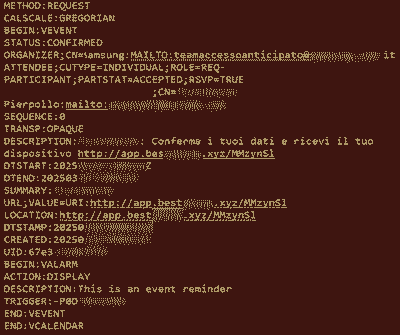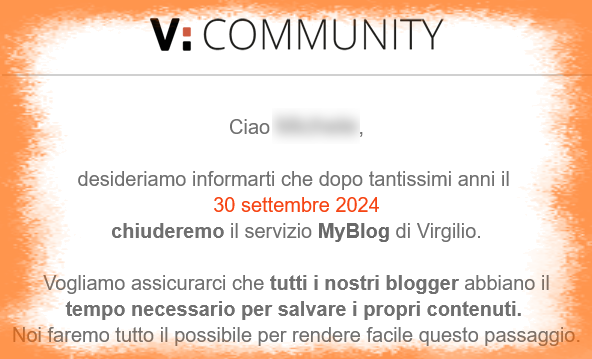Pensavamo di essere noi ad esserci impigriti, a non riuscire più a formulare chiavi di ricerca adeguate alle risorse che bramavamo di trovare. Che abituati troppo bene dall’efficienza di Google avessimo perso memoria degli arcani incantesimi che rivolti al moderno oracolo di Mountain View ci aprivano le porte di nuovi universi del sapere. Che i nostri ricordi facessero clamorosamente cilecca e che in realtà nulla di quel mondo fosse mai esistito. Invece no, erano proprio i motori di ricerca ad aver intrapreso un percorso di inabissamento dal quale non riescono più a risalire. Conviene farsene una ragione, i motori di ricerca sono ormai pressoché inutili al netto di un paio di funzioni residue ancora non del tutto travolte dal decadimento.

Google sembra aver perso quella che era la sua prerogativa migliore, la capacità di dare ordine ai risultati di ricerca dando priorità a quelli più rilevanti. Una caratteristica fondamentale quando si utilizza un motore di ricerca senza sapere preventivamente dove approdare. Con un progressivo deterioramento iniziato probabilmente attorno al 2010, la SERP [1] di Google è stata invasa da contenuti di qualità scadente, spesso perfino indecente. Qualsiasi ricerca non banale si traduce in una miriade di risultati inutili, tutti creati con lo stesso schema compositivo, tutti inutilmente prolissi, tutti di utilità pressoché nulla. Potremmo parlare di una vera e propria rivincita delle content farm [2] che sono ormai in grado di dominare le prime pagine dei risultati di qualsiasi motore di ricerca con investimenti via via sempre più marginali. Chi mette in piedi questo genere di contenitori non si fa grossi scrupoli a saccheggiare il contenuto originale della rete, ad assemblarlo in stile Frankenstein, a produrne mille combinazioni differenti, a tradurlo meccanicamente in ogni lingua con un minimo di seguito.
Tutto questo peraltro ben prima dell’esplosione dell’intelligenza artificiale, i cui effetti si vedranno ancora più nettamente da qui a qualche tempo. Con le AI verrà meno anche la necessità di procurarsi materiale originale e l’intero processo di invasione potrà essere gestito algoritmicamente.
Google, ma anche Bing non si scosta di molto, sembra incapace di individuare dei pattern in grado di riconoscere e penalizzare i contenuti generati dalle content farm. Le logiche di ordinamento che premiano il recentismo, l’ottimizzazione per il mobile, la struttura rigida del contenuto si sono rivelate un boomerang devastante per la qualità dei risultati relegando all’invisibilità tutto ciò che non è aggiornato, non è mobile-first, non fa uso di un ristretto e rigido vocabolario commerciale (gratis, migliore, alternativa, e via di questo passo).
Dal momento che parliamo di colossi dalle risorse quasi illimitate è tuttavia lecito chiedersi se detti pattern siano effettivamente impossibili da formalizzare o se viceversa non vi sia alcun interesse a farlo. Dopo tutto i grandi motori di ricerca sono diventati da tempo macchine pubblicitarie il cui scopo non è fornire informazioni all’utente ma condurlo opportunamente nelle mani degli inserzionisti, gli unici che come entità paganti hanno diritto a qualcosa.
Cosa resta dunque? Gli unici due contesti in cui ancora ha senso affidarsi ad un motore di ricerca sono tra loro diametrali. Chi conosce già la destinazione della sua ricerca (un servizio, una azienda, un nome) può usare un motore di ricerca per associare quella informazione nota con l’indirizzo URL a cui è raggiungibile. Ma è evidente in questo caso come il motore di ricerca sia di fatto declassato a poco più di un gestore di segnalibri; e d’altro canto il numero di persone che inseriscono un nome in Google per raggiungere siti abituali è incredibilmente più alto di quanto possa sembrare. L’altro scenario sono le chiavi di ricerca altamente specialistiche, quelle combinazioni di parole tipiche di gerghi tecnici e specialistici priva di un significativo interesse commerciale e per tanto poco presidiate dai generatori automatici di contenuti.
Conviene dunque entrare nella logica che la ricerca orizzontale su Internet sia morta e cominciare seriamente ad individuare strategie alternative. Ma di questo magari parleremo in un’altra occasione.
~
L’immagine in questo post è stata generata utilizzando una intelligenza artificiale · Commenti? · 1. search engine results page · 2. Le content farm sono aziende specializzate nel produrre contenuti ottimizzati per i motori di ricerca; in passato hanno spesso sfruttato il lavoro sottopagato di tanti freelance anche se ormai operano principalmente attraverso strumenti automatizzati a cui si è accennato sopra.